
Siamo ormai giunti alla fine della seconda settimana di quarantena, dopo il DPCM del 7 Marzo u.s. e successivi, che prima consigliavano caldamente e poi disponevano, con sanzioni penali in caso di infrazione, l’isolamento di ciascuno nella propria abitazione, a fine di evitare l’ulteriore diffusione del virus covid-19. Ma quali sono gli effetti della quarantena sul benessere psicologico dell’individuo? È indubbia la necessità di tale misura restrittiva della libertà di ognuno, in un momento tragico della storia dell’umanità; pertanto il primo assunto deve essere quello di seguire quanto le Autorità Competenti ci dicono di fare (#iorestoacasa). Come ciascuno di noi ha sperimentato nelle scorse settimane, però, tale isolamento diventa sempre più faticoso da sopportare. Una recente review pubblicata su Lacet (Brooks & co., 2020) si concentra proprio sulle conseguenze e i rischi psicologici della misura di quarantena. La separazione dalle persone più care, la perdita della libertà personale, l’incertezza sul proprio stato di salute o di malattia e la noia possono avere degli effetti severi sulla psiche degli individui. Studi epidemiologici su soggetti sottoposti a misure di quarantena evidenziano, infatti, la prevalenza di sintomi post traumatici, depressione, stress, irritabilità, ansia, insonnia, rabbia e esaurimento emotivo, con un permanere di un disagio psicologico anche per mesi e/o anni dalla fine della quarantena. Anche dopo settimane o ad un anno dalla fine del periodo di quarantena, ad esempio, le persone continuavano a presentare comportamenti evitamento di luoghi o persone e comportamenti di controllo quali l’attento lavaggio delle mani. Molte persone riferivano, inoltre, la difficoltà a ritornare ad una “normalità” per molto tempo dopo la fine della quarantena. Ciò che sembra avere un maggiore impatto sul distress psicologico, oltre ai fattori personali già citati, sono: prima di tutto, la durata della quarantena, che, quindi, deve essere protratta solo per il tempo effettivamente necessario e non deve essere prolungata oltre; la paura di essere infettati ha un ruolo considerevole nel generare stress soggettivo; la frustrazione e la noia, legati alla riduzione o alla sospensione delle attività giornaliere in cui ciascuno era impegnato; il timore di non avere abbastanza provviste o possibilità di approvvigionamento; infine, la confusione legata alle informazioni inadeguate ricevute. Riguardo a quest’ultimo punto, sembra utile dare alla popolazione sottoposta a quarantena delle linee guida chiare sulle azioni da mettere in atto, la natura del virus e la possibile durata della quarantena, evitando il più possibile messaggi ambivalenti o passibili di interpretazione. Fattori predittivi di un peggiore impatto negativo della quarantena risultano la giovane età (16-24 anni), la minore scolarizzazione, il sesso femminile e l'avere un solo figlio (avere tre o più figli è risultato fattore protettivo). In tal senso non tutti gli studi sono, però, concordi. Altri fattori di rischio sono il possedere una storia personale di sintomi psichiatrici o essere impiegato nel settore delle professioni sanitarie. In particolare, i sanitari sarebbero maggiormente esposti al rischio di sviluppare sintomi post traumatici, rabbia, fastidio, paura, frustrazione, senso di colpa, impotenza, isolamento, solitudine, nervosismo, tristezza, preoccupazione oltre ad essere maggiore oggetto di stigmatizzazione in caso essi stessi siano stati sottoposti a misure di isolamento. La stigmatizzazione è risultato uno dei fattori di rischio maggiori sia durante la quarantena e che nel post quarantena: diversi lavoro scientifici mostrano, infatti, che i sanitari sottoposti a periodo di quarantena erano frequentemente oggetto di stigma o rifiuto sociale, ad esempio erano evitati attivamente, perdevano possibilità di coinvolgimento in iniziative sociali, erano trattati con paura e sospetto o con commenti critici. Quali fattori, dunque, possono avere un effetto virtuoso nel mitigare gli effetti di distress psicologico della quarantena? Abbiamo già citato l’importanza del dare delle informazioni chiare circa i comportamenti da attuare e da evitare, oltrechè sulla natura del rischio infettivo o sulla necessità di prevedere adeguate forme di approvvigionamento. Risulta efficace, inoltre dare delle informazioni pratiche sulla gestione del tempo e sulla gestione dello stress, per ostacolare le eventuali emozioni di angoscia alimentate dalla noia e dall’isolamento. In tal senso, è utile attivare una rete sociale personale, che ha un effetto di riduzione delle emozioni di ansia e angoscia, oltre che di rassicurazione riguardo al proprio e altrui stato. La possibilità di accedere, tuttavia, anche ad una rete di esperti risulta importante nel ridurre le emozioni negative e nella gestione dell’eventuale comparsa di sintomi, che potrebbero essere male interpretati o per predisporre celeri interventi nel caso emergano sintomi tipici del virus. Infine, risulta molto positiva l’influenza di comportamenti prosociali e di altruismo, ovvero di aiuto alle perone più fragili, nel ridurre lo stress da quarantena. Cosa fare, dunque, per affrontare la quarantena? L'Ordine Nazionale Psicologi suggerisce piccoli accorgimenti da attuare nella quotidianità, per contenere le emozioni di ansia e preoccupazione e mantenere un approccio realista rispetto agli avvenimenti. Tre buone pratiche per affrontare il coronavirus
Buone pratiche L’Istituto Superiore di Sanità indica semplici azioni di prevenzione individuale. Eccole qui riassunte:
L’uso regolare di queste azioni elementari riduce significativamente i rischi di contagio per sé, chi ci è vicino e la collettività tutta. Se, nonostante questi accorgimenti, l'ansia e la preoccupazione diventano eccessive, Non ti vergognare di chiedere aiuto. Tutti possiamo avere necessità, in certi momenti o situazioni, di un confronto, una consulenza, un sostegno, anche solo per avere le idee più chiare su ciò che proviamo e gestire meglio le nostre emozioni, e questo non ci deve far sentire “deboli”. La comunità degli psicologi si è organizzata per consulenze a distanza per offrire il giusto supporto a chi ne ha bisogno. Bibliografia - Brooks, S., K., Webster, R., K., Smith, L., E., Wooland, L., Wessely, S., Greenberg, N., et al. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Published: February 26, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8 - CNOP (2020). VADEMECUM PSICOLOGICO CORONAVIRUS PER I CITTADINI. Perché le paure possono diventare panico e come proteggersi con comportamenti adeguati, con pensieri corretti e emozioni fondate. Consultabile su: https://www.psy.it/vademecum-psicologico-coronavirus-per-i-cittadini-perche-le-paure-possono-diventare-panico-e-come-proteggersi-con-comportamenti-adeguati-con-pensieri-corretti-e-emozioni-fondate  Emergenza Covid-19. Quali effetti della quarantena sul benessere psicologico? didott.ssa Maria Luisa Abbinante è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
0 Commenti
Il 10 Ottobre 2017 si celebrerà per il secondo anno consecutivo la "Giornata Nazionale della Psicologia". Lunedì 9 Ottobre 2018, nell'ambito di tali celebrazioni, la dott.ssa Maria Luisa Abbinante, psicologa-psicoterapeuta, sarà a disposizione delle persone che si prenoteranno per rispondere a domande relative ai servizi offerti, tipologie di intervento, percorsi, tempi e costi. Prenota la tua visita attraverso il form che troverai in fondo alla pagina e non dimenticare di lasciare il tuo numero di cellulare! 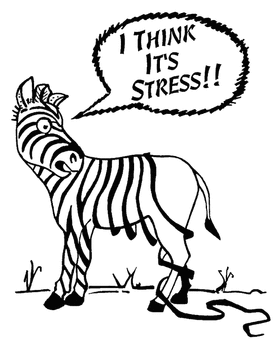
Finite le tanto desiderate vacanze e ripreso il solito tran tran quotidiano, è alto il rischio di ritornare in fretta nell'occhio del ciclone dei mille impegni familiari e professionali, con un innalzamento dei livelli di stress che rischia di vanificare in breve tempo gli effetti positivi del maggiore riposo delle vacanze.
Cosa è lo stress? Come fare per non rimanere di nuovo sue vittime? Lo stress è una risposta non specifica dell'organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso. Qualunque richiesta, anche la più banale, causa uno stress perchè richiede all'organismo di modificarsi ed adattarsi alla nuova condizione (sindrome di adattamento). Di fronte ad uno stimolo stressante (stressor), il soggetto cercherà una forma di adattamento: valuterà l’evento che deve essere affrontato, cercando una strategia per farvi fronte. Se, nel breve termine, sarà capace di reagire alle pressioni cui è sottoposto, recuperando la condizione di equilibrio iniziale, le pressioni possono essere considerate positive: si parla di eustress o stress positivo. Se, al contrario, le condizioni sfavorevoli supereranno le capacità e le risorse del soggetto oppure saranno prolungate nel tempo, l’individuo diventerà incapace di reagire e offrirà risposte poco adattive: questo viene definito distress o stress negativo. Il distress è associato ad un vissuto di minaccia e può essere causato da una mancanza/carenza di risorse per far fronte al problema oppure da uno stress che dura a lungo nel tempo (stress cronico). Contrariamente a quello che si può comunemente pensare, la totale mancanza di stress è negativa, poiché è associata ad una situazione di letargia, apatia, mancanza di entusiasmo, noia. In una situazione di benessere, infatti, l'individuo deve avere una minima fonte di sollecitazione, di eustress, che lo stimola. La presenza di stress positivo, di eustress, è associata ad una condizione di successo, positività, energia. Come faccio a distinguere uno stress positivo ed uno stress negativo? La percezione dello stress è fortemente soggettiva ed è mediata sia dalle caratteristiche dello stressor, che dalle caratteristiche e risorse del soggetto. Tanto più la fonte di stress è intensa o prolungata nel tempo, tanto più questa causerà un disagio nelle persone. Due persone nella stessa situazione, invece, avranno una capacità di fronteggiare lo stress completamente differente, che dipenderà dalle caratteristiche personali, che porteranno ciascuno a privilegiare un tipo di risposta piuttosto che altre, in base a ciò che sa fare meglio o alle proprie esperienze personali. Un ruolo importante è, inoltre, svolto dagli gli apprendimenti, che determinano la possibilità di riproporre strategie che si sono già rivelate efficaci in passato. 
Ma che cosa è l'adattamento? In che cosa consiste?
Ogni volta che uno stressor perturba l'equilibrio, l'organismo cerca di ritrovare l'omeostasi, ovvero l'equilibrio perduto, attraverso reazioni fisiche, mentali, neurofisiologiche. Le possibili risposte allo stress possono essere:
L'adattamento è un'attività complessa e consiste nella messa in atto di azioni finalizzate alla gestione o soluzione dei problemi, alla luce della risposta soggettiva suscitata dagli eventi fonte di stress. Le azioni volte ad accrescere l'adattamento potranno essere rivolte sia al soggetto, che modificherà qualcosa nel suo funzionamento attuale per consentire il raggiungimento di un nuovo equilibrio, sia all'ambiente, che sarà modificato o riorganizzato alla luce delle nuove esigenze. Si parla di sindrome generale di adattamento proprio per indicare la risposta del soggetto ad una situazione di stress. Tale sindrome si articola in tre fasi:
Suggerimenti per migliorare la capacità di far fronte allo stress al lavoro
di dott.ssa Maria Luisa Abbinante
 Penso che sia stress... didott.ssa Maria Luisa Abbinante è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale. 
Ogni anno, alla fine delle vacanze si desidera che quella sensazione di benessere e relax conquistata non ci abbandoni tanto in fretta. Eppure alto è il rischio di riprendere quelle cattive abitudini che avevano portato all'esaurimento psico-fisico prima della partenza, tornando rapidamente a lasciarsi travolgere da mille impegni familiari e professionali. Cosa fare per combattere lo stress della sindrome da rientro? Il rientro dalle vacanze è vissuto, il più delle volte, come la fine del tempo da dedicare a sé, alo svago e al divertimento, oltreché alle cose che più ci piace fare. Ma chi ha detto che in città non si possano ricreare delle situazioni simili a quelle che tanto hanno permesso il ristoro psico-fisico durante le vacanze? Questo è un pregiudizio comune, che rischia più di tutto di generare un cortocircuito di stress negativo. Ecco che il primo obiettivo del rientro deve essere quello di organizzare delle occasioni positive, stimolanti e rilassanti: un week-end con gli amici, una cena nel locale preferito, un pomeriggio in spa, un aperitivo con le amiche, qualunque cosa vi piaccia fare. Per stare bene le persone hanno bisogno di avere una minima fonte di sollecitazione, di eustress. La presenza di stress positivo è associata ad una condizione di benessere, successo, positività, energia, mentre la totale mancanza di stimoli è negativa, poiché, a lungo andare, genera noia e apatia. Passare il week-end sul divano a ricordare con malinconia il periodo di ferie è controproducente. Secondo obiettivo sarà quello di favorire le attività all'aria aperta, come camminate al parco, giri in bici, escursioni nei dintorni. Durante le vacanze aumentano le attività all'aria aperta, che mettono in moto il corpo e favoriscono il relax e la possibilità di "staccare la spina" con il lavoro e gli impegni: perchè non provare a mantenere questa sana abitudine? Terzo obiettivo sarà dedicarsi alla cura di sé, ad esempio preparando i piatti preferiti e riprendendo l'attività sportiva, beneficiando degli effetti positivi del movimento. E al lavoro? Per mantenere nel tempo la condizione di rilassamento e benessere conquistata durante le vacanze anche al lavoro prova a:
Questi piccoli e apparentemente banali suggerimenti ti aiuteranno a concentrarti sul tuo benessere e a mantenere uno sguardo equilibrato sulle tue giornate, senza farti travolgere dalle richieste esterne.  Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Capita a tutti di passare momenti difficili, in cui tutto sembra andare storto e si ha la sensazione che le energie si stiano esaurendo completamente.
Può capitare di sentirsi particolarmente inquieti, nervosi, in cerca di risposte o, al contrario, con la sensazione che sia necessario un cambiamento al più presto ma senza riuscire a comprendere la direzione da prendere. Capita, anche, che la fine di una relazione, di un amore, di un'amicizia ci lasci esterrefatti, confusi, arrabbiati, a domandarci da dove ripartire. A chi rivolgersi? In queste circostanze i primi ad accorrere in nostro aiuto sono i nostri amici, parenti, colleghi, ma non sempre i consigli e le risposte amorevolmente offerti riescono a farci stare meglio.
Altro interlocutore può essere il medico di base... ma se le cose vanno così...
Può anche capitare di pensare rivolgersi a lui...
Tante soluzioni diverse al nostro stato di malessere.
Ma siamo sicuri di avere ricevuto le risposte di cui avevamo bisogno? #VoltaPagina Hai mai pensato di rivolgerti ad uno psicologo? O sei tra quelle persone che credono ancora alla bufala "Dallo psicologo ci vanno solo i pazzi" ? I video sopra mostrati fanno parte di una miniserie promossa dall'Ordine Psicologi Lazio nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione e promozione della professione dello psicologo.
di Dott.ssa Maria Luisa Abbinante
 #VoltaPagina didott.ssa Maria Luisa Abbinante è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. Based on a work at http://www.ordinepsicologilazio.it/voltapagina/.  La "Settimana di Prevenzione dell'Invecchiamento Mentale" è una iniziativa che si propone di promuovere uno stile di vita orientato al mantenimento del benessere fisico e mentale nelle persone non più giovani. Perché questa iniziativa? La "Settimana di Prevenzione dell'Invecchiamento Mentale" nasce perché nonostante che molte persone invecchino bene fisicamente, presentano problematiche cognitive (smemoratezza, disattenzione, disorientamento e via dicendo) che rischiano di peggiorare la qualità di vita. Spesso accade che la persona si rassegni passivamente a questo lento declino mentale e cognitivo. E' sbagliato rassegnarsi. La scienza ha ampiamente dimostrato che appropriati esercizi mentali, corretta alimentazione e movimento fisico permettono di mantenere a un livello costante e ottimale l'abilità, la flessibilità e prestazioni delle funzioni cognitive. A chi si rivolge l'iniziativa? L'iniziativa si rivolge a chiunque voglia conoscere lo stato di salute delle proprie abilità mentali. Non ci sono vincoli per parteciparvi. salvo volersi prendere cura di se stessi fin da subito. In cosa consiste il check-up? Il test è individuale e consiste in prove "carta e matita", che dureranno al massimo circa 45 minuti. Al termine dei test riceverai informazioni personalizzate sul funzionamento delle principali attività cognitive, quali memoria, attenzione, concentrazione, linguaggio. Potremo cercare insieme dei piccoli compiti ed attività che potranno aiutarti a mantenere in ottima forma le tue abilità cognitive. Il check-up è gratuito. Puoi prenotarti direttamente compilando il modulo qui sotto lasciando un riferimento telefonico o mail e verrai ricontattato per fissare il tuo check-up. In alternativa puoi chiamare il numero 393 850 9837. Articolo originale pubblicato su http://brainfactor.it/index.php?option=com_content&view=article&id=717:indagine-preliminare-sullapplicazione-del-metodo-ermeneutico-fenomenologico-alla-process-research&catid=46:integrazioni&Itemid=3 Secondo Di Nuovo (2007), affinché la psicoterapia possa definirsi sperimentalmente convalidabile occorre che si avvalga, per la verifica delle proprie ipotesi, della triplice procedura adottata dalle scienze naturali, che ottenga cioè una convalida logica, una convalida pragmatica e una convalida esplicativa.
La convalida logica pertiene alla coerenza tra teoria psicopatologica, obiettivi terapeutici e tecniche di intervento, e ha lo scopo di acquisire una concordanza tra le nuove conoscenze e il corpus teorico che né è matrice. La convalida pragmatica concorre alla verifica degli effetti: una strategia d’intervento è valutata secondo criteri di efficacia e di utilità. Questo approccio è definito in letteratura “outcome research” in quanto fondato sulla valutazione del risultato per mezzo di confronti pre e post-terapia ed eventuali follow up (Migone, 1996). La convalida esplicativa pertiene invece all’ambito della “process research” che considera il processo terapeutico nel suo incedere: è l’evolversi del cambiamento del paziente a essere posto a tema dell’indagine attraverso momenti di assessment periodici (Di Nuovo, 2007; Migone, 1996). Questo tipo di approccio è finalizzato a fornire il senso di ciò che accade in terapia definendo, al di là dell’esito, perché il trattamento funziona o meno. Il “cambiamento” può essere valutato secondo modalità essenzialmente quantitative, qualitative o attraverso una procedura mista. La valutazione quantitativa, sostanziando l’effetto esperienziale della terapia in misurazioni psicometriche, prescinde però perlopiù dal «Chi» del paziente (e del terapeuta); coglie il “quanto” ma non il “come” del processo terapeutico (Liccione, 2011; Liccione, 2012; Allegri et al., 2011; Petesi et al., 2011). L’alternativa qualitativa, invece, attraverso metodologie come l’analisi del discorso e l’analisi narrativa intende cogliere il senso del processo clinico, con specifico riferimento ai processi terapeutici che sottendono il cambiamento esperienziale del paziente (Di Nuovo, 2000). L’approccio ermeneutico fenomenologico, coniugando lo studio dell’autobiografia - nell’accezione ricoeuriana di identità narrativa - e lo studio dell’esperienza in prima persona, fornisce una possibile metodologia di analisi del processo terapeutico a contributo degli studi sulla process research. Esperienza e raccontoIl racconto di sé è la riconfigurazione narrativa della propria esperienza. Secondo Ricoeur (1990) la concatenazione di eventi che costituisce l’intreccio di una storia, consente di combinare la “stabile” permanenza del protagonista nel tempo (medesimezza), con la variabilità e la discontinuità dell’esperienza (ipseità). L’intreccio, dunque, possiede una propria forma di identità dinamica attuata attraverso la seconda fase della Mimesis (riconfigurazione), che permette la “sintesi dell’eterogeneo” e, conseguentemente, “la concordanza discordante”: viene così risolta l’urgenza di armonizzare la narrazione secondo un principio d’ordine includendo discordanze minaccianti l’unità della stessa. Tuttavia, parte importante della psicopatologia origina proprio da modalità non identitarie di riconfigurare l’esperienza in racconto (alterazione identitaria) (Liccione, 2011; 2012). L’obiettivo della terapia diventa pertanto la trasformazione di Sè, che accade quando, attraverso il racconto in terapia e l’attuazione delle consegne fornite dal terapeuta, il paziente riconosce dei modi esperienziali non identitariamente riconfigurati o non affatto riconfigurati. Applicazioni e metodologia in una psicoterapia individuale di 22 seduteLo scopo del nostro lavoro è apportare un contributo alla process research attraverso l’applicazione di una metodologia di analisi qualitativa fondata sul metodo ermeneutico-fenomenologico. Il materiale su cui è avvenuta l'analisi è composto dalle trascrizioni delle videoregistrazioni di un intero percorso psicoterapeutico, costituito da 22 colloqui, distribuiti lungo l'arco di 11 mesi. La variabile d’interesse è rappresentata dallo sviluppo narrativo delle tematiche giudicate significative nel determinare la sofferenza del paziente. La codifica sistematica dei racconti degli episodi, riportati come esemplificativi di una tematica, ha permesso di cogliere le trasformazioni esperienziali. Infatti, come sopra sinteticamente accennato, la rifigurazione della narrativa personale non è un cambiamento dei punti di vista bensì la conseguenza dei cambiamenti dei propri modi di fare esperienza. La metodologia prevede i seguenti passaggi:
Nell’esempio clinico considerato, i risultati della codifica mostrano come da un punto di vista quantitativo la frequenza di episodi critici riportati lungo il corso della terapia e in ogni singolo colloquio decrescono sensibilmente nelle fasi finali della terapia: il paziente riferisce sempre meno situazioni di sofferenza e i singoli colloqui diventano via via monotematici (es.: grafico 1). Circa l’evolversi del cambiamento si riporta, a titolo esemplificativo, l’analisi di uno dei temi più significativi tra quelli emersi nella terapia del caso clinico preso in esame in questo lavoro: sentirsi non considerati/svalutati da parte dell’alterità. La “non considerazione” rappresentava un tce di estrema rilevanza, contestualizzato nell’intreccio di una storia di vita caratterizzata da una costante assenza di scambi interattivo-affettivi fin dall’infanzia. La maggior parte delle situazioni relazionali caratterizzate da un rifiuto (es.: non ricevere un finanziamento dalla banca), venivano riconfigurate dal paziente nei drastici termini di una non accettazione personale, perlopiù legata all’idea di non essere considerato degno, adeguato, capace, ecc. La disposizione emotiva generata da queste esperienze ha condotto, nel suo perpetuarsi, alla storicizzazione di sentimenti di rabbia e di sofferenza in ogni occasione di percepita svalutazione da parte dell’alterità. Nei primi colloqui, alla tematica si associano vissuti di ansia, ruminazione, insonnia e inazione, accompagnati da emozioni intense di rabbia, inadeguatezza, irritazione, odio, disagio, fastidio, tristezza, dispiacere, rassegnazione, inquietudine, rimorso e delusione. La mancata appropriazione esperienziale del paziente si esplicita nello spiegarsi la sofferenza come una conseguenza dei comportamenti inadeguati degli altri e non dei propri modi di essere (grafico 2). A seguito degli interventi del terapeuta, mirati a contestualizzare le emozioni e a permettere al paziente di creare parallelismi tra diverse esperienze appartenenti allo stesso tce, il paziente arriva in seduta portando spontaneamente una riflessione, esemplificativa dell'appropriazione dell'esperienza della non considerazione e di un racconto identitario (episodio 6a). In seguito si è potuto osservare un numero più esiguo di episodi problematici appartenenti al tce (non considerazione), e la sofferenza diviene meramente esistenziale. Il paziente riporta ancora episodi legati alla non considerazione, essendo questo un tema storico, ma le emozioni che vi si accompagnano assumono valore in relazione al contesto e alla rete coerente di rimandi. In altri termini, nell’esempio considerato (tce: non considerazione), si nota in modo evidente come il paziente, in seguito all’appropriazione occorsa in seduta (6°) della propria specifica modalità esperienziale, inizi a trasformare la modalità esperienziale stessa, rendendola emotivamente meno intensa e quantitativamente meno frequente. ConclusioniQuesto metodo di analisi del testo, qui sinteticamente esposto solo nelle sue linee generali, e al momento applicato a una sola psicoterapia, intende fornire un contributo metodologico e scientifico alle indagini della process-research. A partire da un insieme di temi critici esistenziali, che il terapeuta può formalizzare a partire dagli episodi raccontati dal paziente, risulta possibile un’analisi temporale dell’andamento degli stessi, sia sul versante della loro frequenza, sia sul versante della loro specifica modalità di manifestazione (natura degli episodi nei quali il tce occorre, qualità emotiva associata, ecc.). Inoltre, e questo dalla nostra ricerca preliminare sembra essere l’aspetto più importante, questo tipo di analisi ben si presta a correlare gli interventi del terapeuta con l’appropriazione/rifigurazione esperienziale del paziente circa i tce considerati. Bibliografia

Il termine resilienza viene dal latino <<resalio>> che significa saltare/rimbalzare.
In psicologia col termine resilienza si indica la capacità del soggetto di adattarsi agli eventi avversi della vita. La resilienza è, dunque, la capacità di un soggetto di mantenere un discreto livello di adattamento nonostante le circostanze sfavorevoli. Secondo Michael Rutter, la resilienza è la capacità di svilupparsi in modo accettabile, nonostante la presenza di uno stress o di un’avversità che comporta normalmente il rischio di un esito negativo. Si tratta, quindi, non solo di capacità di resistere alle avversità, ma soprattutto di capacità di superare le difficoltà: la persona resiliente, infatti, quando è sottomessa a pressioni, non soltanto resiste, ma è in grado di proteggere la sua integrità, di costruirsi ed aprirsi strade alternative. Ne sono una dimostrazione i sopravvissuti ad eventi traumatici o altamente stressanti: accanto a persone che rimangono irrimediabilmente segnate dalle esperienze vissute, ci sono persone che, al contrario, riescono ad utilizzare quelle esperienze per apprendere qualcosa di sé o dell'ambiente che li circonda. La resilienza è, in altre parole, la capacità di trasformare un'esperienza difficile, dolorosa o stressante in un apprendimento. La persona resiliente, infatti, è capace di acquisire delle competenze utili al miglioramento della qualità di vita e all’organizzazione di un percorso autonomo e soddisfacente, nonostante la difficoltà. Se l'ambiente in cui l'individuo si ritrova a vivere è ostile o non accogliente, il soggetto con una buona capacità di resilienza riuscirà ad adattarsi, promuovendo un cambiamento di sé che faciliti quell'adattamento. Si tratta, dunque, di un processo di continuo riadattamento, che la persona mette in atto di fronte alle avversità che incontra nella sua vita riuscendo a crescere e vivere “sana” pur in condizioni svantaggiate. Caratteristiche La resilienza non è statica, ma dinamica. Ogni situazione, ogni momento storico della vita di una persona o di una società porterà ad un rimaneggiamento della capacità di resilienza di ognuno. La resilienza, infatti, è il risultato dell'interazione dinamica di 3 elementi, che sono:
Per spiegare bene il concetto Anthony ha proposto la cosiddetta metafora delle 3 bambole. Se prendiamo 3 bambole composte da materiali differenti (vetro, plastica e acciaio) e diamo a ciascuna bambola un colpo di martello di pari intensità, gli effetti del colpo saranno differenti a seconda del materiale di cui è fatta la bambola: la bambola di vetro si frantumerà in mille pezzi; la bambola di plastica riporterà una cicatrice permanente; la bambola in acciaio non subirà alcun danno. Tale metafora è stata ripresa e modificata da Manciaux, che ha sottolineato che la capacità di resilienza di un individuo non dipende solo da fattori personologici, ma è il risultato dell'interazione di più fattori. Se lasciamo cadere una bambola, quindi, l’oggetto si romperà più o meno facilmente a seconda: - della natura del suolo: cemento, sabbia… - della forza del lancio: negligenza o aggressione - del materiale di cui è fatta: vetro, porcellana, pezza o acciaio. Il suolo rappresenta l’ambiente/contesto nel quale il soggetto vive (familiare, sociale e culturale); il lancio rappresenta l’evento difficile o traumatico vissuto, lo stressor; la resistenza del materiale è il livello di vulnerabilità legato alla personalità del soggetto. Strategie utili per sviluppare resilienza:
di Dott.ssa Maria Luisa Abbinante  La resilienza: cos'è? didott.ssa Maria Luisa Abbinante è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale. 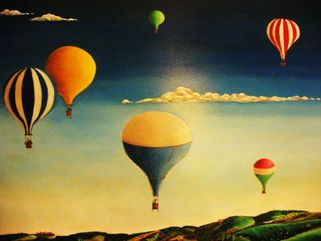
La conoscenza e la comprensione della lingua italiana rappresentano due delle principali difficoltà che i minori immigrati, sia di prima che di seconda generazione, si ritrovano a dover affrontare al momento del primo ingresso a scuola italiana. Gli stessi educatori, sia della scuola materna che della scuola primaria, spesso rimandano agli operatori sanitari il sospetto di disturbi specifici del linguaggio (DSL) o, più avanti nel tempo, di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
In realtà parlare di DSL o DSA nei bambini immigrati è alquanto pericoloso, per il rischio di scambiare per DSL o DSA, ovvero per disturbi con una forte matrice neurocognitiva, una difficoltà che è legata all'apprendimento della seconda lingua, l'italiano. Questi bambini sono, infatti, a tutti gli effetti dei bambini bilingui, con tutte le problematiche che la letteratura associa all'apprendimento di una seconda lingua in termini fonologici, lessicali, morfosintattici e pragmatici. È possibile distinguere diverse tipologie di bilinguismo:
I bambini immigrati, sia di prima che di seconda generazione, difficilmente si ritrovano in una condizione di bilinguismo simultaneo. Nella maggior parte dei casi, infatti, questi bambini hanno un accesso alla L2, l'italiano, a carattere intermittente ed episodico sino all'ingresso alla scuola materna, che diventa il contesto di principale socializzazione alla lingua e agli usi e costumi della cultura italiana. In molti casi si assiste, da questo momento in poi, ad uso settoriale delle due lingue: a casa la prima lingua, L1, a scuola l'italiano, L2. Tale condizione, inevitabilmente, determina delle difficoltà e problematicità, che potrebbero essere erroneamente riconosciute dagli operatori scolastici come DSL o DSA. Si sono moltiplicati negli anni numerosi studi che hanno avuto come oggetto l'apprendimento delle lingue in bambini bilingui immigrati. Le teorie a riguardo sono abbastanza contrastanti:
Le principali problematicità dell'apprendimento linguistico nel bambino immigrato riguardano, inoltre:
Uno studio condotto da Pàez e colleghi (2007), infine, dimostra che il bilinguismo sommato alla condizione di migrante può rappresentare un ulteriore fattore di rischio, in quanto i bambini bilingui analizzati avevano prestazioni nei compiti linguistici analizzati di circa 2 d.s. inferiori a quello dei monolingui. Tutto questo significa che non si può fare diagnosi di DSL nei bambini stranieri? Ovviamente no! Una diagnosi di DSL è possibile anche nei bambini non madrelingua italiani, anche se in questi casi la diagnosi differenziale deve essere ancora più precisa ed accurata, che dovrà tener conto, tra le altre cose, dell'età e del tempo di esposizione alla L2. Bibliografia
di dott.ssa Maria Luisa Abbinante  Disturbi specifici del linguaggio nei bambini stranieri: una diagnosi possibile? diMaria Luisa Abbinante è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale. 
Le ricerche epidemiologiche, negli ultimi anni, hanno mostrato un incremento dei tassi di prevalenza dei disturbi psichici in età evolutiva. In particolare è emerso che circa il 10% dei ragazzi compresi nella fascia d'età 14/18 (pre-adolescenti e adolescenti) soffrono di un disturbo psichico di diversa natura.
In tutti i campi della medicina e della salute si diffonde la cultura della prevenzione. Prevenzione, riprendendo la definizione del World Health Organization, non significa soltanto creare le condizioni affinché una condizione di rischio non si verifichi (prevenzione primaria), ma è anche diagnosi precoce (prevenzione secondaria) e intervento tempestivo (prevenzione terziaria). Da qui la necessità, sostenuta a più voci, di individuare precocemente i disturbi psicopatologici gravi (es. le psicosi) con esordio in epoca adolescenziale, al fine di un trattamento precoce. L'intervento precoce, infatti, aumenterebbe la recovery dei pazienti, con un minore rischio di cronicizzazione del disturbo, minori tassi di disabilità e compromissione del funzionamento generale, sociale e lavorativo e minore ricorso al ricovero ospedaliero. In effetti, da più fronti, la ricerca ha evidenziato che il mancato intervento, nei casi di disturbi psicopatologici gravi, porta ad una progressiva perdita delle abilità cognitive e sociali del soggetto, che, a loro volta, offrono un terreno fertile ad un ulteriore peggioramento sintomatologico e comportamentale. Il Piano Nazionale Salute Mentale (2013) sostiene la necessità di dare avvio ad esperienze cliniche sperimentali dedicate alla fascia adolescenziale, ponendo particolare attenzione agli esordi di disturbi psicologici gravi e alla necessità di integrazione con i servizi di salute mentale dedicati agli adulti. Il trattamento dei disturbi psichici nella fascia d'età adolescenziale, infatti, presenterebbe non poche criticità, tra cui: la scarsa afferenza di adolescenti e pre-adolescenti alle unità operative di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza, che rimangono entro il 4% nonostante la stima della psicopatologia si attesti attorno al 10%; le difficoltà nella gestione delle acuzie psichiatriche in adolescenza, a causa del numero esiguo di posti letto e di reparti di neuropsichiatria atti ad accogliere le urgenze, che porta spesso a dei ricoveri impropri; il passaggio della presa in carico dalla neuropsichiatria alla psichiatria al compimento del 18°anno di età, spesso difficoltoso a causa della mancata integrazione dei servizi. Costruire un servizio dedicato alla diagnosi e trattamento precoce dei disturbi psicopatologici in adolescenza significa, quindi, porsi in un'ottica di:
Come detto sopra, parlare di diagnosi precoce è particolarmente importante quando si affronta il tema delle psicosi. La ricerca, negli ultimi anni, ha sostenuto la possibilità di individuare precocemente situazioni di rischio di esordio psicotico, gli Ultra High Risk o Stati Mentali a Rischio, che individuano soggetti, considerati a rischio di sviluppare un disturbo grave, sulla base della presenza di segni e sintomi considerati prodromi dei distubi psicotici (Edwards & McGorry, 2002), Più in generale possiamo distinguere diversi stadi che portano alla manifestazione psicotica, che sono:
Hafner (1996) sostiene che, in media, tra la comparsa dei primi segni di malattia e l'esordio psicotico acuto passano circa 5 anni, periodo che potrebbe essere sfruttato per attivare interventi volti a prevenire la comparsa della franca psicosi o a minimizzarne le conseguenze: l'intervento precoce, infatti, produce effetti favorevoli a lungo termine sul decorso dei sintomi negativi, depressivi e cognitivi, oltrechè sul funzionamento sociale dei soggetti. Intervenire al fine di riddurre la durata della psicosi non trattata (DUP), quindi, significa migliorare l'outcome e la recovery di tali soggetti. Tale possibilità di maggiore recupero in caso di intervento precoce deriva dalla teoria del deficit neuromaturazionale, la teoria più accreditata in questo momento sull'eziologia delle psicosi e della schizofrenia, che postula che ci sarebbe una vulnerabilità biologica (innata o acquisita) alla psicosi, quella che molti autori chiamano schizotipia. Non necessariamente tale vulnerabilità porta alla psicosi franca, ma può esitare in una serie di sintomi o quadri sub clinici, come disturbi schizoidi o schizotipici. Tale vulnerabilità rimarrebbe latente per tutta la prima infanzia (sebbene possano esserci alcuni elementi che, a posteriori, sono valutati come fattori di rischio permanenti), per poi essere pienamente espressa a partire dall'adolescenza, con la quasi completa maturazione del sistema nervoso centrale. Se la teoria del deficit neuro-maturazionale è vera, quindi, permettere ai soggetti che presentano segni di rischio di accedere ad interventi terapeutici e di sostegno dovrebbe diminuire l'impatto di tale deficit e interrompere la spirale che porta al graduale peggioramento dei sintomi. Bibliografia
di dott.ssa Maria Luisa Abbinante  Esordi Psicopatologici in adolescenza: la necessità di integrazione, diagnosi precoce e trattamento tempestivo. didott.ssa Maria Luisa Abbinante è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale. |
dott.ssa Abbinante
È Psicologa Consulente presso l'UONPIA (Unità Operativa di NeuroPsichiatria dell'Infanza e dell'Adolescenza) della ASST Rhodense di Garbagnate Milanese nell'ambito del Programma Innovativo Regionale “Procedura Operativa dell'emergenza/urgenza psichiatrica in adolescenza”, dove si occupa di diagnosi e trattamento di disturbi psicopatologici con esordio in adolescenza. Si occupa di valutazione e trattamento di esordi psicopatologici nell'infanzia e nell'adolescenza, di interventi di supporto della genitorialità, di sostegno psicologico a persone con malattia cronica e di prevenzione ed intervento precoce nella fragilità dell'anziano. Argomenti trattati nel sito
Tutto
Archives
Marzo 2020
|



 Feed RSS
Feed RSS


